WAYNE HORVITZ, Those Who Remain / The Snowghost Sessions
Qualcosa di autunnale ci sta uccidendo. Chiamala
guerra, o febbre. Lo sai quando la vedi: una fiammata.
La vite e il fuoco e il cervo del mattino arrivano
in mezzo secolo a centellinare la sua primavera là,
al limite più lontano delle sue terre, avvolti nel cellophan di luce.
Ciò che vive è ciò che lui ha lasciato nell’aria, preciso,
non visto, appeso dove lui stava il giorno in cui urlò.
Un orso si aggira ogni giorno più vicino alla sua baracca.[…]
Richard Hugo
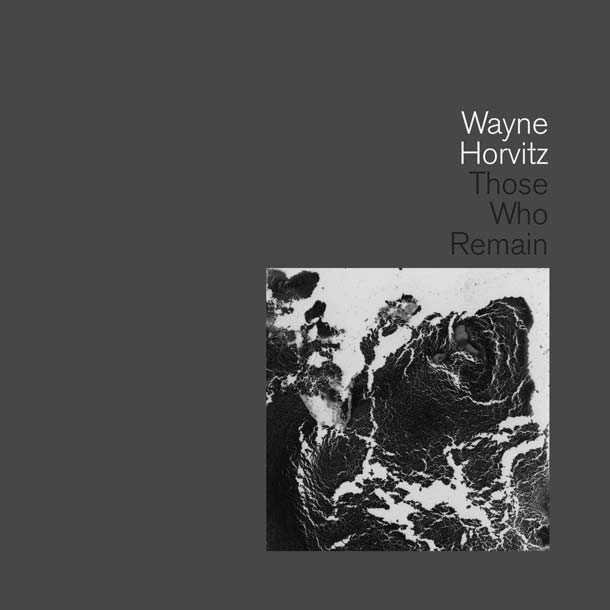
Questi versi, dal poema “Contadino morente”, restituiscono perfettamente l’atmosfera da frontiera inesplorata, da tempo di conquista, che si respira nel primo dei due lavori di Wayne Horvitz che qui vi raccontiamo. Parliamo di Those Who Remain (Concerto For Orchestra And Improvising Soloist), ispirato alle poesie di Richard Hugo (1923-1982), autore che cantava le immense distese dell’America, la profonda depressione economica degli Stati Uniti rurali, le piccole città in declino, le fabbriche abbandonate. C’è un che di profondamente drammatico e neorealistico nei racconti in versi di questo autore indomito che viaggiò per la costa pacifica del Nord Ovest dando voce ai derelitti. Gli risponde in modo luminoso e tragico una musica nitida e affilata: stanze novecentesche (gli archi, avvolgenti e sempre pronti a convocare divinità dallo sguardo austero), una scrittura matura, da compositore di classica contemporanea, che oscilla con sapienza tra fragori (il primo movimento della title-track, pienamente sinfonico e capace di evocare scenari grandiosi, precipizi sconfinati, confini esistenziali), veglia, melodia e astrazione (il secondo movimento, con Bill Frisell sugli scudi alla chitarra elettrica solista, magistrale). Deliziosi labirinti in cui perdersi i quattro movimenti di “These Hills Of Glory”, per quartetto d’archi e solista improvvisatore (Odeonquartet e Beth Fleenor al clarinetto). Lunghi piani sequenza, figure affilate e sottilissime, cadere da un cielo dove non pascola nemmeno una nuvola, assaporare l’aria rarefatta e unica delle cime. C’è chi sostiene che i quartetti d’archi siano tre le forme d’arte musicale più avanzata e profonda che abbiamo la fortuna di sperimentare. Questi lo confermano in pieno. Da ascoltare in religioso silenzio, cercando di carpire un segreto indicibile che trascende le possibilità delle parole. Un disco bellissimo, debutto orchestrale per il compositore del 1955, con un illustre passato alla corte di John Zorn nei Naked City, e, a quanto ci è dato di ascoltare, con un presente luminoso quanto il futuro spalancato davanti a sé.

Negli ultimi venti anni, il leader ha prodotto soprattutto materiale sul versante classico, componendo, tra le altre cose, cinque quartetti d’archi, un oratorio, due lavori per orchestra da camera e un lavoro per orchestra, come quello di cui abbiamo detto proprio ora. Questo, invece, è il primo disco che Horvitz (qui a pianoforte, live processing, Wurlitzer, Hammond B-3, Nord Lead, Tx-7 e Mellotron) concepisce e registra in trio, dopo quelli degli anni Ottanta (come Some Order, Long Understood, con Butch Morris e William Parker, pubblicato da Black Saint nel 1982, oppure Nine Below Zero, sempre con Morris ma con Bobby Previte, su Sound Aspects, 1987). Entrato in uno studio/santuario per audiofili a Whitefish in Montana, senza una lista di pezzi né un obiettivo chiaro, nemmeno quello di far uscire un disco dalle sessioni, Horvitz, assieme ai collaboratore di lunga data Geoff Harper (contrabbasso) ed Eric Eagle (batteria) scrive di aver semplicemente goduto del lusso di poter usufruire di una residenza in un ambiente molto accogliente assieme a musicisti con i quali la conoscenza è intima. Il risultato è semplicemente magnifico. Da composizioni più riflessive ed assorte, leggermente attraversate da perfette interferenze elettroniche che straniscono il tutto (“The Pauls”, la traccia d’apertura) a momenti melodici e ariosi che sfociano in astrazioni avant-pop (“No Blood Relation#1”), il disco è una continua sorpresa e la conferma dello stato di grazia di questo autore, che ha da poco pubblicato per la Novara Jazz Series anche un altro lavoro come compositore e direttore della sua European Orchestra, registrato alla Bimhuis di Amsterdam in occasione del quarantennale di quel luogo leggendario. Haiku che sono memori di Bill Evans (“Trish”), ipotesi di incontro tra minimalismo, ambient e swing graffiante (“IMB”), e così via, in un continuo caleidoscopio di stimoli e suggestioni che catapulta l’ascoltatore in posti sconosciuti, notturni e bellissimi, sensuali, pericolosi e avvolti in una perenne bruma che sa di veglia o di inizio di qualcosa che non sappiamo dire. Horvitz si diverte con il laptop, processa il suono (“Yukio And Nao’s Duet”), sperimenta con il piano amplificato, cercando di dare nuove prospettive al classico trio jazz. Fondali boreali, piani sequenza, malinconie da grandi spazi, notti interiori, preghiere su spartito, improvvisazione sottovoce. Tutto rotola e funziona a meraviglia in un lavoro che, in modo molto naturale, suona come attraversato da un vento che scompiglia le idee senza buttare nulla all’aria. Ombre di blues, come in “55 6 (21) Variations”, che nella sua revisione successiva, “55 6 (7) Variations” scovano altri spigoli, restando in equilibrio da qualche parte tra tematismo e astrazione zen. Ottima davvero la sensibilità per i timbri e stupefacente l’uso profondamente espressivo e lirico di ogni sorgente di suono (le tastiere sembrano a volte chitarre, e non sono mai essere superflue, eccessive o didascaliche): un disco di cui innamorarsi, da custodire con cura per quando torneranno i primi freddi.
