RICHARD SKELTON, Selenodesy
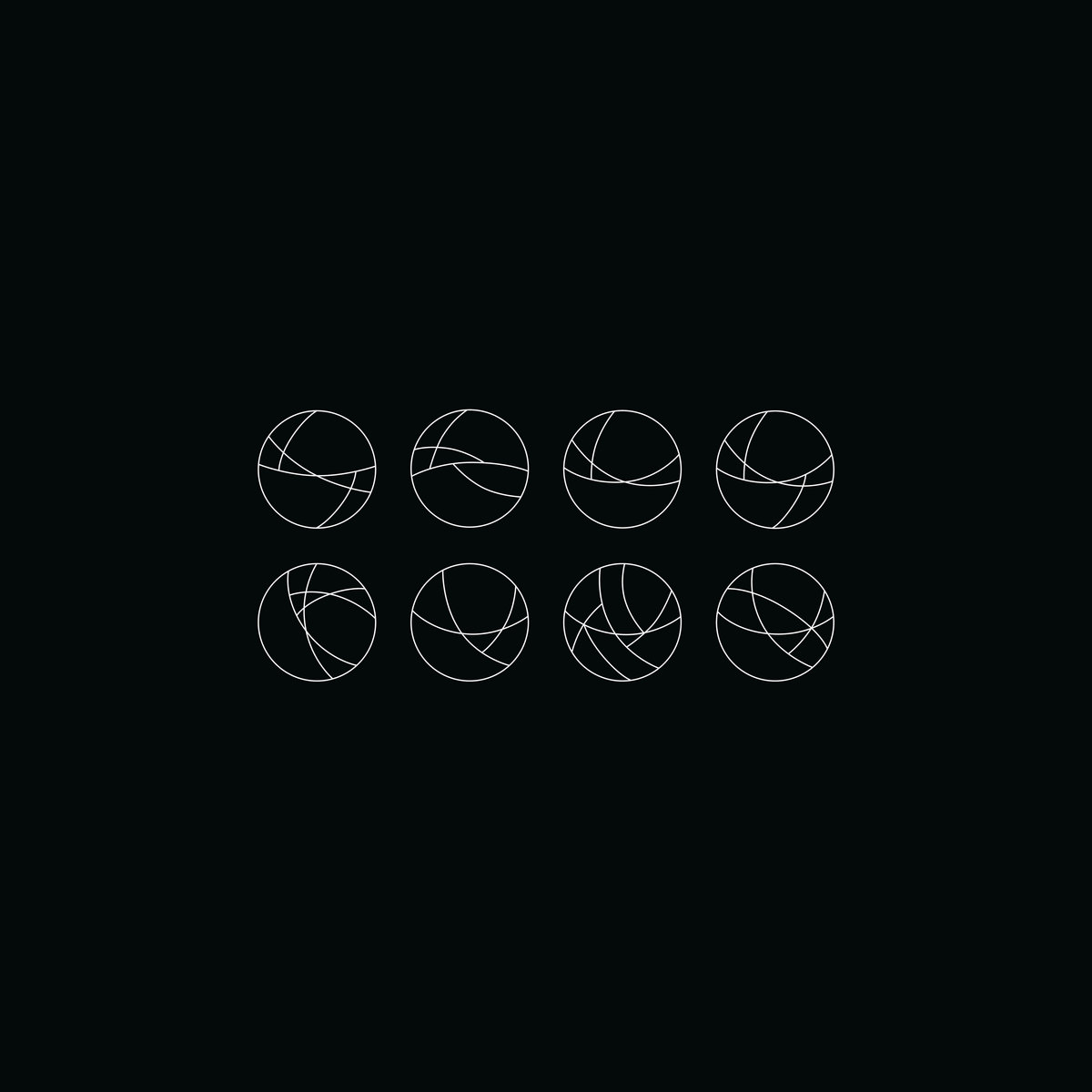
Richard Skelton, da 18 anni a questa parte, si è costruito un mondo. Lo ha fatto in maniera personale, rispecchiando sé stesso e l’ambiente nel quale si trova attraverso strumenti e trattamenti sonori. Tutto questo a volte ha trovato la via dei dischi, a volete delle esibizioni.
La “selenodesia” è lo studio della luna, satellite quasi sempre visibile e quasi mai compreso dalla nostra porzione terrestre. In Selenodesy Richard muove l’ennesimo passo lungo un percorso che pare essere solitario e luminoso, fatto di movimenti e di squarci. Un percorso di comprensione e di posizionamento, durato una fase di insonnia.
Il suono appare grande, enorme, stagliato e in lento movimento. Materico senza abbandonare una sognante orecchiabilità, a tratti granuloso. Possiamo pensare a Richard Skelton come a un musicista che, tramite strumenti che dissotterra, corde, software, riesca a creare un determinato stile ambient. Possiamo però anche chiudere gli occhi, sentendolo come un tramite, un corpo che effettua azioni ispirato, guidato e costretto da qualcosa più grande, un satellite bianco, nero e lontano. I toni bassi ed i vibrati ci mantengono legati all’idea di una gravità percepita, di una mole del suono e di un incombente contatto (“Impact Theory”) che riportano alla statica drammaticità di opere visuali analoghe (“Another Earth” di Mike Cahill, “Melancholia” di Lars Von Trier). I brani ci parlano però di moti in divenire, di sciabordii e di flutti, di maree. Ci parlano della fine della paura, di fisicità, di azioni e reazioni, dettati dall’entrata nell’orbita di una o dell’altra sfera.
Ci parlano di dolore, facendoci temere sul finale di poter soccombere, graziandoci poi.
Non so come Richard Skelton estragga questi suoni, ma credo che il riuscire a trasportarci in quella precisa posizione sia risultato degno di merito.
