Notizie dal diluvio #7: ANTS Records

Hai bussato
al polmone, hai tolto
la linguetta perché partisse
il meccanismo, il mio
chiamarti.(Elisa Biagini, Filamenti, Giulio Einaudi, Torino, 2020)
A New Timeless Sound: un nuovo suono senza tempo, oppure, più prosaicamente (ma la prosa della natura, lo sappiamo, è poetica) formiche; questa la dichiarazione d’intenti dell’ottima ANTS Records, prestigiosa etichetta con sede a Roma e un catalogo per palati fini di cui andremo a raccontare tre numeri in questa nuovo episodio di Notizie Dal Diluvio. Innanzitutto una notazione biografica: ho conosciuto l’etichetta ascoltando i dischi dell’anno di Battiti, ed in particolare la puntata dove l’amico Ariele Monti, di Area Sismica, elencava i suoi cinque preferiti: tra questi Again &Again di Manuel Zurria, di cui vi dirò a breve. Partiamo invece da un lavoro che è addirittura del 2019 ma è talmente splendido che merita di essere raccontato, e chissà che a qualcuno non venga in mente di ripescare questa perla.
R KEENAN LAWLER & JOHN KRAUSBAUER, Spectre Of Radiants
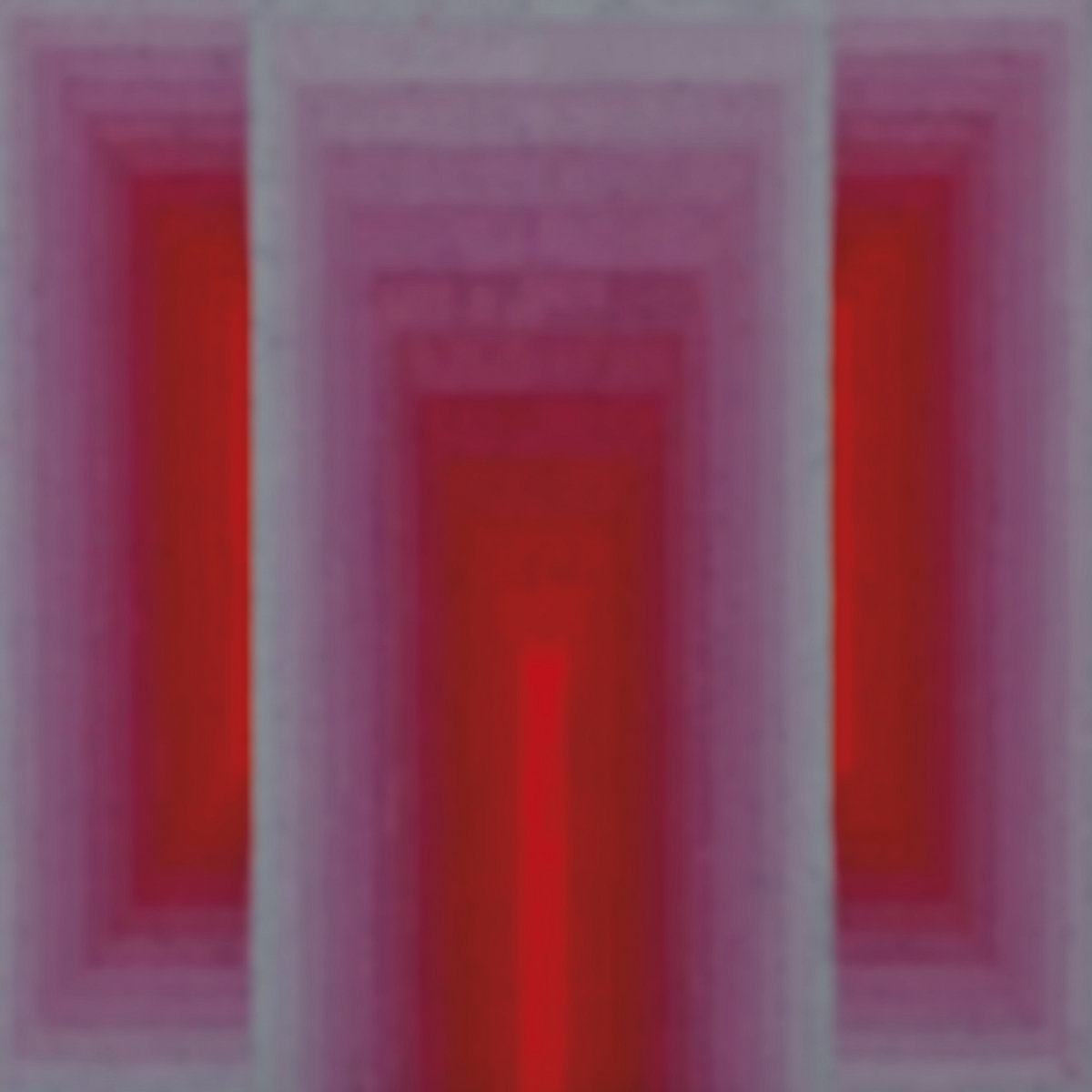
Con questo disco l’innamoramento è stato istantaneo; anche ora che scrivo interrompo il flusso e di nuovo sono brividi, anche se l’ho già ascoltato decine di volte; la magia e il mistero del puro tono si ripetono ancora una volta e noi non possiamo fare altro che cercare, con le nostre povere, sghembe parole, di restituirli. Lawler, da Lousville, Kentucky alle National Steel resonator guitars e Krausbauer ai banjos, suonati in maniera non convenzionale, costruiscono una magnifica cattedrale di suono nitido nella quale sedersi e perdersi, ammirando le navate, osservando la luce piovere da distanze intime ed infinite. Lo stesso senso di struggimento di certe pagine di Jim O’Rourke (penso a I’m Happy, I’m Singing & a 1,2,3,4, su Editions Mego) mondato però di quel senso di fine imminente e rivolto ad un’alba del mondo, come un acido senza alcun effetto collaterale, o una seduta di mescalina col dottor Conrad per dieci anni lungo il piano infinito. Bagliori, satori, il grande romanzo dell’epica americana polverizzato in uno sconfinato piano sequenza; chissà che immagini ci monterebbe sopra Werner Herzog, di quali folli ci parlerebbe, di quali esploratori, di quali innamorati del mondo, di quali indomiti camminatori sull’orlo dell’abisso: noi, barricati nella nostra sala in una domenica arancione scuro in piena terza ondata, alziamo il volume e sentiamo tutto un brulicare di sinapsi che si accendono, un brivido fisico, un’eccitazione elettrica passarci per il corpo, abitato da un’ipnosi pre-alfabetica e curativa, portata da un suono che vibra da qualche parte tra la scintilla che unisce drone, raga e bluegrass e i rituali arcaici da cui la musica in quanto tale si abbevera. Lawler nel suono cerca la trascendenza ed ha orizzonti spalancati sia per quanto riguarda gli ambiti musicali, sia per le collaborazioni, che lo hanno visto al fianco, tra i tanti, di Matmos, Pelt, Rhys Chatham, Susan Alcorn, Helena Espvall e Jim Carroll. John Krasbauer è alla ricerca della totale immersione attraverso l’ur-drone e il suo lavoro ha a che fare con un’idea di totale immersione sensoriale: missione in questo caso perfettamente compiuta. Quarantaquattro minuti e dodici secondi di purissima, purissima magia, un’unica traccia estatica, una scia di meraviglia che sarà impossibile togliere dal vostro impianto se non quando si sarà spenta in un naturale, nuovo, accogliente silenzio. Questa musica custodisce segreti e potrebbe cambiarvi la vita.
MANUEL ZURRIA, Again & Again

Manuel Zurria, classe 1962, è un flautista e polistrumentista italiano per il quale hanno scritto, tra gli altri Stefano Scodanibbio e Philip Corner e che, come performer, ha suonato musiche di Terry Riley, Arvo Pärt, Alvin Curran, Frederic Rzewski. Questo doppio è il capitolo finale di una trilogia in 7 cd dedicata al minimalismo, cominciata con Repeat! (Die Schachtel, 2007) e passata per Loops4ever su Mazagran nel 2011. Again & Again, uno dei dischi dell’anno scorso, come dicevo all’inizio del pezzo, per Ariele Monti (al quale sono unito, oltre che da una profonda stima per quanto fa per le musiche non allineate da innumerevoli anni, anche da una certa affinità di orecchio), racchiude quasi due ore e mezzo di musica che, dice il press kit, ti faranno volare. Si apre il sipario con un breve sketch per voci e percussioni e giocattolo “Számzene I – Counting Music (for Tom Johnson)” di László Sáry, per poi visitare altri cieli con i sedici minuti che non lasciano scampo di “Dance#2”, un Philip Glass del 1979; spirali, rifrazioni, poliritmie, veglia, fughe, estasi, stasi. Felicemente ambiguo ed elusivo, nella sua breve durata, il canone, tautologicamente intitolato “Canon”, di Adrián Demoč, scritto proprio per Zurria, per quattro flauti alti. Perfetta la “Clapping Music” di Steve Reich che nel 1972 inventa la minimal techno su un inesorabile tempo di 6/8. Da Shining arcaico i labirinti nella neve ritmico-armonica di “Carduelis” di Rytis Mažulis, per dieci flauti: ascoltare ad occhi chiusi e non capire se si sta salendo al cielo o scendendo nelle tenebre degli abissi, per poi ricordarsi che siamo semplicemente fermi al solito posto. Fulcro del primo volume la fluviale, magnifica “Dorian Reeds” di Terry Riley, originariamente per sassofono (qui sostituito dai flauti) e delay, venti minuti, stanze e distanze da qualche parte oltre le nuvole delle nostre intenzioni, ed i diciotto di “Dance #4”, ancora di Glass, scritta per organo e qui eseguita in una versione per flauti, field recordings e percussioni giocattolo: il Novecento che si specchia ed ammicca sornione, l’ombra della storia, un esito che suona perfettamente naturale per un lavoro di trascrizione che invece, confessa lo stesso Zurria nella gustosa autointervista del libretto, gli ha portato via tempo ed energie. Il sipario, per il primo tempo, si chiude con l’enigmatica “Bagatelle” di Howard Skempton.
Nel secondo cd per davvero si decolla, in un posto che non sappiamo descrivere ma dove l’ossigeno è delizioso e rarefatto, con “7 Flutes” di Kevin Volans, sottile e affilata, o con la “Reed Phase” (1966) di Steve Reich, in una versione per tre flauti e percussioni giocattolo, come un gamelan in una scatola di fiammiferi, o come un giocattolo per un bambino di un paio di secoli che sfugge alle leggi della biologia. L’interesse per i musicisti dell’Est, ampiamente rappresentati nel doppio, dalla Lituania (Mažulis e Kabelis), presente nel secondo volume con la straniante bellezza di “Kalno Sutartine (VII)”, per addirittura 72 flauti (!), alla Slovacchia (Demoč), fino all’Ungheria (Sàry e Szemző, la cui “Water Wonder” per quattro flauti e delay è un ottimo esercizio di speleologia acustica) è legato al desiderio di Zurria d’esplorare un altro lato, meno conosciuto, del movimento minimalista. “Tutto si ripete, ma ogni volta è come se fosse la prima, l’idea del sacrificio condensa rito e santificazione di un gesto”. Ispirato da una intervista del regista teatrale Pippo Delbono, Zurria riporta queste sue parole per cercare di dare una voce ed una descrizione a questi cumulonembi di suono che passano e vanno (la perfetta apnea di “Harmonium#1” di James Tenney, per dodici flauti e sine waves). Un’opera torrenziale e impalpabile, frutto di un labor limae certosino di (ri)scrittura e interpretazione (quasi tutti i brani erano concepiti per altri strumenti e sono stati trascritti dall’interprete): lievissima e di una densità quasi filosofica, capace, forse senza nemmeno desiderarlo (c’è un che di zen lungo questi infiniti minuti, un mood da assenza di volontà) di lasciarti fiorire in testa idee meravigliose che dimenticherai appena penserai di averle colte. Diceva lo spietato Cioran: “Per scorgere l’essenziale non bisogna esercitare alcun mestiere. Restare tutto il giorno distesi, e gemere”. Che è un po’ come respirare in un flauto, o tacere da soli e semplicemente ascoltare.
WERNER DURAND, Schwingende Luftsäulen 3
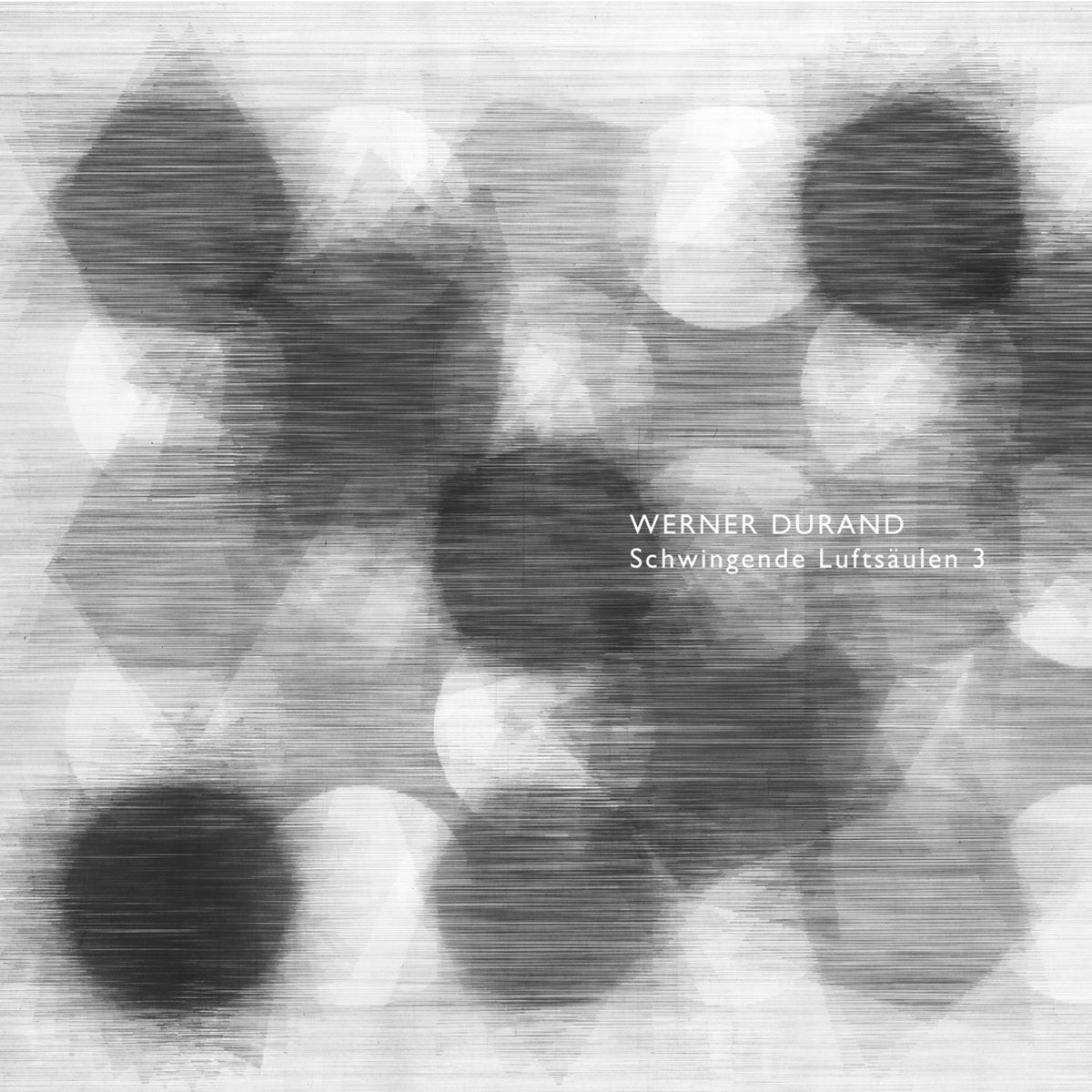
Pubblicato a dicembre 2020, Schwingende Luftsäulen 3 (vibranti colonne di aria in tedesco) è l’ultimo capitolo (anche in questo caso, come per Zurria) di una trilogia (primo e secondo sono usciti sempre su ANTS nel 2017 e nel 2019) dedicata in toto al Pan-Ney, uno strumento fatto di tubi di plexiglass (dai cinque ai sette tubi aperti da entrambi i lati e senza buchi per le dita) sviluppato da Werner Durand nel lontano 1984 e che, contestualmente all’uso di delay digitali, suona come un ibrido tra il flauto di pan, diffuso in tutto il mondo ed il ney, diffuso in una vasto territorio compreso tra il Pakistan e il Maghreb. Quattro esplorazioni in solitaria delle possibilità dell’ipnosi attraverso la ripetizione, fino a delineare un mondo fitto e fatto solo di aria e respiro, templi con, come da titolo, vibranti colonne di aria, monumenti all’impermanenza da ammirare mentre le giornate finalmente si allungano e la luce nonostante il virus dilaghi continua imperterrita a non mancare l’appuntamento e ad allagare le stanze. In “Pearldivers” invece lo strumento magico di Durand è accompagnato dal talking drum di Marika Falk, scendiamo di quota, planiamo sulle acque e ci tuffiamo tra le onde iterative del ritmo e di questa lenta, docile, inesorabile marea. Un suono che riconcilia e per il quale sarebbe naturale tirare in ballo i nomi storici del minimalismo, il Teatro della Musica Eterna, Terry Riley, le fasi di Reich, il mistero del non ripetersi del ripetersi, come scriveva il poeta Hikmet a proposito di Bach, ma è proprio la poesia il modo forse più adatto per restituire il sapore di un disco necessario in tempi malati come questi, un’opera dove la storia sfuma nelle nebbie del mito e i secoli diventano un’epopea lunga minuti: antologia automatica di domande che spuntano in testa e circolano come il sangue; noi sappiamo che il senso sta proprio nel punto interrogativo e non nelle risposte che non esistono, perché la verità esiste solo nella gloria e nella magnificenza del suono.
Quale bianco ricopre il mio nome?
Quale la memoria di ogni cellula?
Quale il rumore della prima sinapsi?
Perché sono in attesa di colore?
Perché la mia tosse è di vetro?
Dove è il tempo nella mia pelle?
Che succede alle palpebre tra battito e battito?
Quale è la luce del sognare?
Perché non sento gli zoccoli dell’ora?
Perché mi preme un chiodo nel petto?
Dove sono i miei denti di latte?
Dove finisci tu?
Dove io comincio?
Qui è come di ghiaccio che si spacca e ringhia.
(Elisa Biagini, ibidem)
