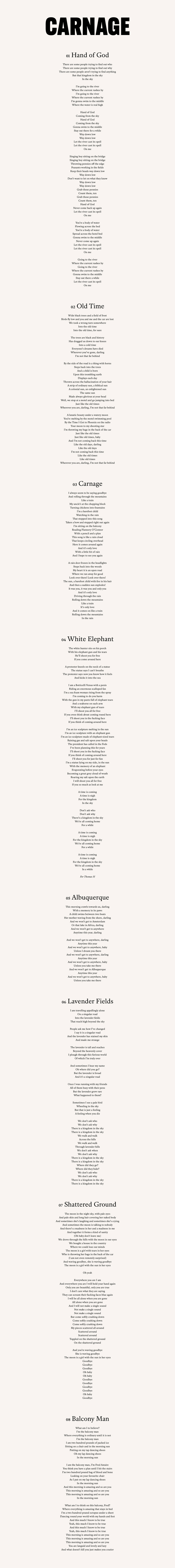NICK CAVE & WARREN ELLIS, Carnage
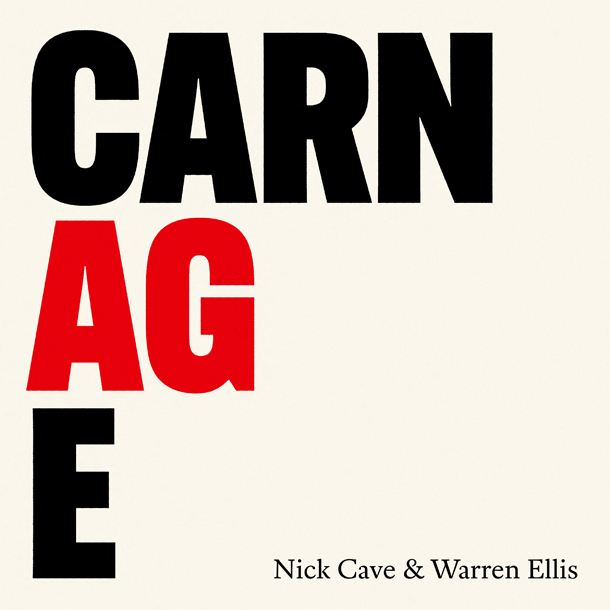
Nella carneficina fisica e mentale che sono i tempi correnti, CARNAGE è arrivato come un colpo di mannaia ben assestato sulle aspettative, pubblicato a sorpresa in digitale per Goliath Records via AWAL Recordings Ltd il 25 febbraio e annunciato in formato fisico il 28 maggio. CARNAGE è peraltro il primo album di canzoni intestato a Nick Cave & Warren Ellis, in aggiunta alla stretta partnership nel campo delle colonne sonore e alla comune militanza nei Grinderman, anche se va detto che l’operato dei Bad Seeds si reggeva in realtà già da lungo corso principalmente su loro due, collaboratori a partire dal 1993 ma via via sempre più uniti da un nuovo e fruttuoso metodo compositivo scaturito dall’improvvisazione, in pratica sempre più “duo” (fatte le differenze del caso, un po’ come Trent Reznor e Atticus Ross).
CARNAGE, per Cave, è anche il quarto capolavoro di fila in questi anni Dieci-ormai Venti così eccezionali, nel bene della qualità artistica e nel male delle vicende personali (la perdita del figlio Arthur, nel 2015). Lo spirito che ha raggiunto la sua catarsi nell’etereo Ghosteen del 2019 lascia adesso la ribalta della scena alla carne, alla crudezza, come se il suo medium, il suo officiante, fosse completamente tornato libero di sporcarsi le mani nel mondo, là fuori, oppure là dentro, nell’isolamento imposto dalla recente emergenza sanitaria mondiale che ha sancito uno stop persino al rito collettivo dei tour. Le registrazioni si sono svolte senza alcun preavviso, nel giro di qualche settimana, in preda ai dettami dell’ispirazione, durante il periodo di lockdown e, non a caso, Cave stesso ha parlato di un disco brutale ma molto bello annidato in una catastrofe comune. Dopo aver appunto elaborato i propri lutti individuali, in una via crucis di introspezione avviata nel 1997 di The Boatman’s Call, distanziandosi così in parte dal vecchio approccio narrativo, Cave ci aiuta a processare il lutto della nostra vita precedente, ovverosia delle libertà e prospettive smarrite a causa della pandemia.
Per quanto più inquieto, il sound continua a svilupparsi in maniera naturale dalla ricerca meno rock e maggiormente sperimentale perseguita in parallelo nelle già citate colonne sonore, così come in Push The Sky Away, in Skeleton Tree e nel medesimo Ghosteen. Proprio come in quest’ultimo, ci sono ancora immagini che ricorrono, mutando leggermente aspetto, apparendo e tornando a ritagliarsi un piccolo spazio, in un mosaico visionario di domande esistenziali, stanze d’albergo, boschi, sfere lunari e caldi raggi di un sole biblico, bambini e figure animali. Soprattutto, ci sono strade sulle quali mettersi alla guida, con le valigie nel bagagliaio, pronti a perdersi, e ci sono numerose forme dell’acqua, tra fiumi, piscine e corpi liquidi, Veneri di Botticelli munite di un pene e donne di schiuma di mare.
“Hand Of God” volge subito gli occhi al cielo, con una partenza in punta di tocchi al pianoforte e una sterzata elettronica dall’incedere spiazzante, resa aliena dall’inserimento degli archi, in un crescendo di inquietudine che sfocia in declamazioni post-punk visionarie nell’annunciare l’intervento di una non molto rassicurante mano divina. Un inizio mozzafiato, al quale fa seguito la nostalgia dark dell’ottima “Old Time”, attraversata dal brivido di un’incessante pulsazione digitale, trascinata nel loop di un pathos atavico da orchestrazioni minacciose, squarciata dalle nevrosi delle scariche elettriche; mentre strane creature con le corna indietreggiano fra gli alberi, il viaggio in auto dei due protagonisti, smarritisi a qualche curva, nel ricordo di un passato perduto, amplifica un senso di perdita che è divenuto universale: We took a wrong turn somewhere / Into the old time / Into the old time, for sure / The trees are black and history / Has dragged us down to our knees / Into a cold time / Everyone’s dreams have died.

A dispetto del titolo programmatico, i toni si fanno più romanticheggianti con “Carnage”, edificata su una struttura più classica, a trainare memorie di infanzia – lo zio che, decapitandoli, tramuta i polli in fontane di sangue – e di letture di Flannery O’Connor, mentre è la musica a rappresentare una salvifica via d’uscita: This song is like a rain cloud / That keeps circling overhead / Here it comes around again / And it’s only love / With a little bit of rain / And I hope to see you again. L’equilibrio è ristabilito/rispezzato con “White Elephant”, forse l’episodio più ardito in scaletta, con una base incalzante che veste da sera moderne influenze filo-hip hop e uno spoken che affronta la violenza da armi da fuoco, la supremazia bianca e il razzismo negli Stati Uniti, rievocando tra le altre cose gli scempi attuati dall’ex presidente Trump e l’assassinio di George Floyd: The white hunter sits on his porch / With his elephant gun and his tears / He’ll shoot you for free / If you come around here / A protester kneels on the neck of a statue / The statue says I can’t breathe / The protester says now you know how it feels / And kicks it into the sea. Alla sua metà, il brano si trasforma però in un gospel corale non si capisce se liberatorio o beffardamente ironico tanto è repentino il cambio di registro e mood (There is a kingdom in the sky).
Si giunge poi ad “Albuquerque”, la ballad più tradizionale del lotto, che stupisce comunque per la profonda emozionalità del testo: And we won’t get to anywhere, darling / Anytime this year. Che sia lo Stato del Nuovo Messico, Amsterdam o l’Africa, non c’è destinazione possibile in questa surreale era di immobilità. Un altro tragitto, stavolta in completa solitudine, è quello intrapreso soppesando le svolte della vita nella morbida eppure a suo modo epica “Lavender Fields” (People ask me how I’ve changed / I say it is a singular road / And the lavender has stained my skin / And made me strange), che sembra riprendere il discorso conclusivo di “White Elephant” in quel gioco di rimandi simbolici a cui accennavamo prima (There is a kingdom in the sky). D’altronde la successiva e iper minimale “Shattered Ground”, pervasa da un fervore lirico incendiario, in perfetto contrasto con la rarefazione di synth archetipici, riprende il racconto di “Old Time” mandando in onda la condivisione in una relazione idealizzata di uno spazio oltre a tutto, oltre alla pazzia e alla sanità, fino alla fine: And there’s a madness in her and a madness in me / And together it forms a kind of sanity / (Oh baby don’t leave me) / We drove through the hills with the moon in our eyes / We bought a house in the country / Where we could lose our minds. Il sipario cala definitivamente con l’ambient neo-classica di “Balcony Man”, dove Cave danza sul balcone come un Fred Astaire in quarantena, in attesa del prossimo mattino. And what doesn’t kill you just makes you crazier. Non fa una piega, no?