GODFLESH, 8/7/2012

Palestrina (RM), Nel Nome Del Rock Festival.
A volte capitano nella vita delle occasioni talmente irripetibili da risultare improbabili al tempo stesso. Mai avrei pensato di poter assistere a un concerto dei Godflesh, con la line-up originale, non a Roma, bensì in quel di Palestrina. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un paese a sud est della Capitale, dove di solito sembra non esserci quasi nulla legato alla musica. Da 23 anni a questa parte, però, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio viene organizzato un festival (Nel Nome Del Rock) diviso in quattro serate di tre o quattro gruppi ciascuna, che anima l’estate in questa località ai piedi dell’Appennino laziale. Le edizioni precedenti possono vantare nomi come Combichrist, Queens Of The Stone Age, Nebula, Forty Winks, Therapy e Massimo Volume, tra gli altri. Quest’anno però, quando nessuno se l’aspettava, gli organizzatori dell’evento hanno pescato un pesce decisamente grosso. Contando il fatto che non si tratta di una semplice data di un tour di reunion, ma di un’ apparizione sporadica, oltretutto l’unica in Italia, per giunta gratis, rende più che ovvia una trasferta immediata. Dopo aver raccolto altri quattro partecipanti, verso le sette e mezzo mi butto in macchina per andarli a recuperare tutti. Le vie per raggiungere il paese sono diverse e per nostra sfortuna all’andata optiamo per una delle più difficili: l’A1, direzione Napoli, con conseguente uscita a San Cesareo. Fino a là tutto ok, ma lasciato il casello ci troviamo in un vero e proprio labirinto di stradine di campagna, nelle quali più di una volta rischiamo di perderci. Ci aspettano 30-40 minuti di tensione, alla fine dei quali arriviamo miracolosamente a Palestrina, rispettando oltretutto i tempi previsti per il viaggio. Purtroppo, però, per una buona volta, gli orari del festival sono stati rispettati, e ci perdiamo gli Anthony’s Vinyls, una band indie/pop della zona. Poco dopo aver parcheggiato la macchina, ci dirigiamo verso la location: un campo storico al centro della città, con un palco di media grandezza, un ottimo impianto e un’ottima acustica. Sul palco ora ci sono i Low-Fi, un quartetto che mischia la new wave con parti electro/indie. Siamo quasi tutti un po’ stanchi del viaggio, visto anche il ripetuto rischio di trovarci – non essendo muniti di navigatore, sperduti nel nulla – e per giunta nessuno di noi è un fan di queste sonorità. Ammetto di non conoscerli e di non poter dare un giudizio sulla loro performance. Dopo una mezzora è la volta degli OVO, un particolare duo veramente difficile da classificare in un genere: i componenti sono Stefania Pedretti. dai dreadlocks incredibilmente lunghi, che si alterna un po’ alla chitarra e un po’ al basso con una maschera sulla faccia, e, conciato come un wrestler, alla batteria (con solo un tom, un timpano e un crash) c’è Bruno Dorella, che milita nei Bachi da Pietra, nei Ronin ed era l’uomo dietro all’etichetta Barla Muerte. Ultimamente, grazie a loro nuovo disco, Cor Cordium, prodotto dalla Supernaturalcat Records, sono riusciti a farsi ancora di più un nome, e l’affluenza alla loro performance è tutto tranne che ridotta. Li avevo sentiti di sfuggita precedentemente girovagando su internet e rimango molto colpito mentre eseguono i loro pezzi. Le parti vocali sono urla e screaming quasi in libertà, che sicuramente hanno una logica, ma che è tutto fuorché facilmente percepibile. Pochissimi accordi, molto rumorismo e sperimentazione, con ritmi ossessivi ma allo stesso tempo molto variabili. È arduo rimanere indifferenti di fronte a una proposta sonora così peculiare, tutt’altro che di facile ascolto. Sebbene siano riusciti a mantenermi ben attento per tutta la durata della loro esibizione, non riesco a sintonizzarmi con la loro proposta musicale. Per fortuna, col passaggio dalla chitarra al basso, le cose sembrano farsi più invitanti: nella mia mente una distorsione così marcata mi ricorda a tratti un gruppo che amo, i Man Is The Bastard, sebbene non sembrino un’ influenza della band (ma magari lo sono, visto questo strano mosaico di suoni). Terminato il loro show, l’attesa cresce per gli headliner.
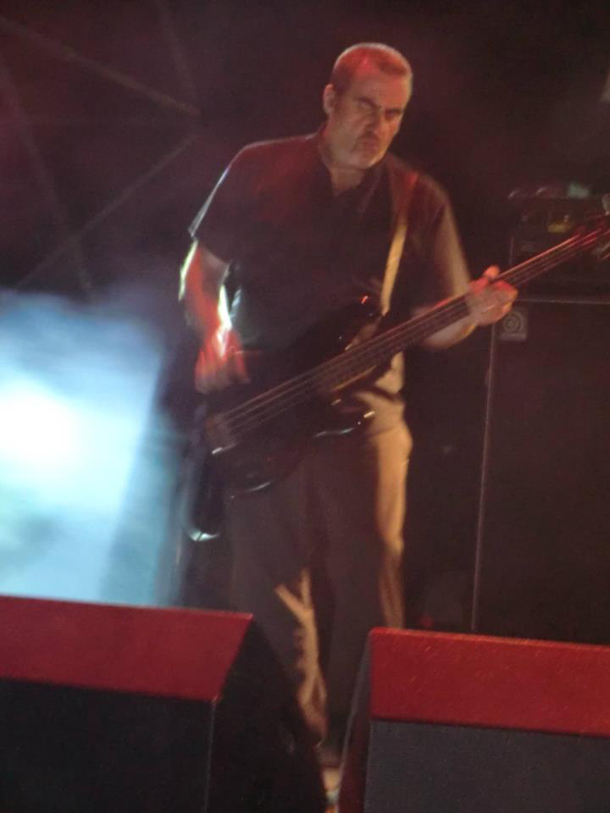
Non appena è il turno dei Godflesh, appare chiaro che non si tratterà di un concerto come gli altri: attaccano subito con “Like Rats”, accolta dall’emozione generale del pubblico presente. Justin Broadrick e G. C. Green hanno sul volto i segni dell’età, ma suonano come se non se ne fossero mai andati e, anzi, sembrano avere ancora molte cartucce da sparare. La seguente, come è facile immaginare, è il brano che aspetto di più, ed è “Christbait Rising”: l’esecuzione è magistrale, un vero e proprio vulcano che erutta lava industriale mista a negatività esistenziale, che piacevolmente devasta le orecchie dei presenti. Come se non bastasse, sempre dallo stesso disco estraggono la title-track, “Streetcleaner”, con tanto di quell’ “I didn’t hear voices…” come intro iniziale. Mi era giunta voce che l’avrebbero suonato tutto per intero: anche se in fondo rimane il mio preferito della band, per fortuna, oltre a “Life Is Easy”, “Tiny Tears” e “Dead Hand”, non sono state eseguiti brani da quest’album, lasciando spazio anche al resto del repertorio del duo. A parte un grande telo, sul quale sono proiettate immagini di diversa natura, spesso astratte, colpisce molto il fatto che quest’incredibile muro di suono non sia altro che frutto di una strumentazione molto essenziale: ampli Marshall con due casse per Broadrick e sempre una testata e coppia di casse per Green. Eccetto la maestosa e martellante “Avalanche Master Song”, il resto della setlist sarà composto di pezzi provenienti da Pure, Slavestate e Selfless. Un problema con la chitarra, una Schecter 7 corde, produce un cambio con una Stratocaster color panna, il che mi fa sorridere, essendo questa più tipica per il blues e per il rock che per la loro proposta sonora. Ora la lava si fa meno bollente e l’atmosfera si fa più psichedelica: un vero e proprio trip industriale. Come è lecito aspettarsi, in brani come “Spite”, “Slavestate”, “Pure”, “Mothra” e “Crush My Soul” la componente metal è minoritaria e c’è più spazio per rumorismi e sperimentazioni. La location rende ancora più bello lo spettacolo al quale assisto: proprio alla sinistra del palco si possono ammirare le case arroccate e illuminate del resto del paese, mentre i due di Birmingham mettono a ferro e fuoco il campo sportivo. A un certo punto si fermano, Broadrick dice “We’re Godflesh, thank you!” e vanno dietro le quinte. Ovviamente tornano per un bis, ed ecco che parte un’unica canzone, la conclusiva “Slateman”. Finita quest’ultima, rimane sul palco solo Broadrick per due-tre minuti di feedback solitari, con la Strato rivolta verso l’amplificatore. Alla fine di questa lunga e intensa performance, rimaniamo tutti veramente entusiasti: chi li ha visti negli anni d’oro ha potuto confermare il loro perfetto stato di salute, manifestatosi in uno show quasi superiore rispetto a quelli dei primi Novanta. Da quel momento, fino al ritorno a casa, il mio umore è alle stelle. Per mia fortuna, grazie ai consigli dei cartelli scelgo un’altra strada e arriviamo tutti prima a destinazione, chi più, chi meno, consci di aver assistito al concerto dell’anno.
