Blues Bag

Il clarinetto basso, rispetto al suo nobile antenato, in ambito jazz è entrato quasi subito nella modernità, apparendo sulle scene con l’arrivo di Eric Dolphy a fine anni Cinquanta (se escludiamo Harry Carney, che talvolta lo alternava al sax baritono nell’orchestra di Ellington). Grazie a lui si è inserito appieno nei linguaggi sperimentali e contemporanei e il musicista afroamericano ne ha tracciato, fin dal suo esordio, le coordinate future, anzi, si può dire che per certi versi ha fatto per il clarone quello che Benny Goodman ha fatto per il clarinetto: ha posto su di esso una seria ipoteca stilistica dalla quale è stato difficile uscire o prendere le distanze. Poi, lentamente ma con costanza, altri lo hanno utilizzato con successo, primo fra tutti Bennie Maupin, peraltro uno dei pochi a differenziarsi da Dolphy. Tutto questo per dire che, a un certo punto, ascoltatori e musicisti stessi s’incuriosirono, compreso, anche se per poco, Buddy De Franco, uno dei rari clarinettisti bopper. E la ragione della presenza di quest’ultimo in Weird Tales è doppia: è stato appunto l’unico, vero clarinettista bop, accanto a Tony Scott come si sa, ma rispetto a quest’ultimo meno interessato alle bizzarrie, alla spiritualità orientale o alle sfuriate quasi vicine al free, bensì legato in modo stretto al linguaggio parkeriano, quasi calligrafico, ma con uno strumento che di quel linguaggio era stata la vittima; l’altra ragione riguarda proprio il clarinetto basso, e la vedremo più avanti.
Di chiare origini italiane (come molti clarinettisti), nasce in New Jersey nel 1923 ma cresce a Philadelphia e, dopo una prima esperienza al banjo, passa subito allo studio del clarinetto. Già all’età di quattordici anni vince il premio Tommy Dorsey e inizia subito a lavorare con le orchestre swing, all’epoca sulla cresta dell’onda. Per sfortuna lui è ancora troppo giovane per assaporare a pieno i successi del fenomeno swing, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, insieme alle orchestre, inizia ad andare in crisi. A differenza dei vari Goodman, Shaw, Herman, lui però non si rassegna a fare da comparsa o a ritirarsi e decide di continuare a suonare anche quando viene investito dal ciclone Be Bop, che rivoluziona il jazz e lo riporta nelle mani e nelle note degli afroamericani. A causa anche delle sonorità più forti e potenti, infatti, il clarinetto, complice il suo recente passato di strumento swing a forte impronta bianca, in pratica scompare a favore di sassofoni, trombe, persino tromboni. De Franco, però, non molla, non cambia e, insieme ad un altro grande outsider come Tony Scott (che peraltro imbracciava talvolta anche il sax), accetta la sfida bop e si converte, nonostante le complicazioni, al nuovo linguaggio.

Fraseologia ricca, suono pieno, grande abilità e virtuosismo, completa padronanza in ogni registro, Buddy De Franco per anni viene votato come miglior clarinettista, anche se spesso questa sua grande bravura lo rende talvolta freddo, oppure poco innovativo, attento soprattutto a esibire il suo enorme talento. Ma ascoltarlo su disco (e immaginiamo anche dal vivo) talvolta è uno spettacolo, per via di fraseggi veloci, volate, arpeggi e porzioni melodiche di rara efficacia. Insomma, a ribadire ciò che si è detto sopra, una sorta di Parker del clarinetto, a voler semplificare. Si limiterà sempre ad ambientazioni mainstream, di rado spingendosi in territori impervi, fuori dai cliché. Album con Art Blakey, Oscar Peterson, Sonny Clark ma anche Count Basie, Art Tatum, Terry Gibbs, fino a dirigere, dal 1966 al 1974 la Glenn Miller Orchestra, che di fatto rappresenterà una sorta di prepensionamento per uno degli ultimi bopper ancora in circolazione.
A rompere questo quadro abbastanza coerente e stabile arriva, nel 1964, la proposta di Leonard Feather di registrare un album che si iscriva nell’alveo del nuovo jazz, seppur non propriamente free, comunque distante dal mainstream così come dal classico bop. Una sorta di sfida ma anche una possibilità di traghettare nella modernità qualcuno che fino ad allora se ne era tenuto ben fuori, soddisfatto com’era della sua attività artistica. Curiosamente, un’operazione che ricorda ciò che il trombonista Marshall Brown farà proprio in quegli anni con Pee Wee Russell, altro clarinettista (ne abbiamo scritto in questa rubrica tempo fa!). Con ogni probabilità lo strumento e i musicisti che lo suonavano invogliavano ad operazioni del genere, o – per farla semplice – si tentava di rincorrere il mercato, provando a destare attenzioni su personaggi che erano rifluiti nelle retrovie del jazz.
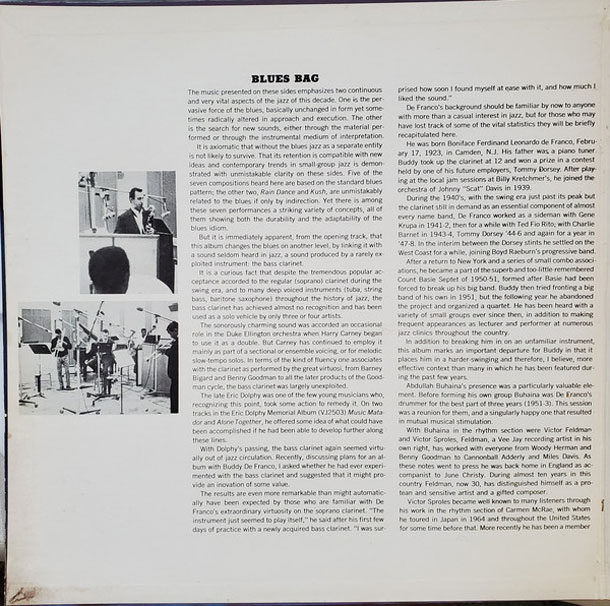
Pianista, giornalista e critico musicale britannico (ma nel 1939 si stabilì a New York), Leonard Feather è fondamentale per la musica jazz, sia come produttore che come musicista, compositore nonché divulgatore e storico. Personaggio unico e attivissimo anche nel campo dei diritti civili, Feather, colpito in modo evidente dai lavori di Eric Dolphy, morto in maniera tragica nel giugno del 1964, propone a De Franco, per il nuovo disco, di rinnovare la sua estetica a cominciare proprio dallo strumento. È vero che clarinetto basso e clarinetto sono parenti stretti, ma per Buddy De Franco di certo è un deciso cambio di rotta, tanto più che inevitabilmente ci sarebbe stato il confronto col fantasma di Dolphy, unico fin lì a suonare con costanza quello strano clarone. La mutazione, però, deve anche riguardare il repertorio e quindi, oltre a “Blues Bag” dello stesso clarinettista, a “Straight No Chaser” di Monk e a Kush di Dizzy Gillespie, vengono inseriti nella lista “Blues Connotation” di Ornette Coleman, “Cousin Mary” di John Coltrane, “Rain Dance” di Victor Feldman e “Twelve Tone Blues” proprio di Leonard Feather. A fianco di Buddy De Franco una line up anche qui particolare e innovativa: Victor Feldman al piano, già con Miles Davis in Seven Steps To Heaven e col quale De Franco aveva in passato collaborato, il suo vecchio amico Art Blakey (in questo disco con il nome musulmano Abdullah Buhaina), Victor Sproles al contrabbasso, con Blakey nei Messengers di quegli anni, e una serie di ospiti significativi come Lee Morgan e Freddie Hill alle trombe e Curtis Fuller al trombone. Questo, in sintesi, è Blues Bag, registrato nel dicembre 1964 e pubblicato l’anno successivo dall’etichetta Vee-Jay con il sottotitolo Leonard Feather’s Encyclopedia Of Jazz – Jazz Of The 60’s Vol. 2. Messa così sembra una tipica operazione Blue Note anni Sessanta, con quella voglia di giocare e di produrre album dal taglio innovativo pur legati stretti a un jazz di derivazione boppistica. In realtà siamo dalle parti dei Jazz Messengers meno energici e più delicati, e l’operazione modernità è abbastanza sterile, per alcuni versi. Partiamo innanzitutto dal leader e dalla sua sfida. Come ovvio, dal punto di vista stilistico, non c’è nessun accenno ad una modalità sperimentale o di derivazione dolphiana, a parte qualche urletto strozzato, bensì un adeguare il clarone, così goffo e complicato, al linguaggio dello strumento principale di De Franco, il clarinetto. E quindi, paradossalmente, questo disco ha il pregio di farci ascoltare qualcosa di raro, unico, quasi irripetibile: e cioè il clarinetto basso piegato ad un be bop classico, con le tipiche scale e un fraseggio a pieno inserito in quello stile. Nessuno lo aveva mai trattato in quel modo, da un lato perché ostico e in parte inadatto a certe latitudini, ma dall’altra anche perché l’eredità dolphiana ne aveva segnato l’evoluzione e gli approcci. E infine perché era apparso sulle scene proprio quando il patrimonio parkeriano era già stato trasformato e rivoluzionato dal free e dalle esperienze contemporanee. Questa particolarità, questa unicità, depone di sicuro favore del disco, al di là delle qualità e del valore artistico.
Tra segni di pesantezza, esitazioni e qualche manierismo di troppo, De Franco riesce comunque a servirsi quasi del tutto del suo tipico fraseggio, evidenziando la sua classe e la sua destrezza, anche a fronte di palesi difficoltà. Ma abituati alla bellezza formale, alla perfezione dei suoi assoli, quelle incertezze, quei suoni fragili e quelle pause, per uno che colmava tutto lo spazio a sua disposizione, assumono per noi un carattere consistente, risaltano con forza. È anche questo che rende curioso e particolare questo disco, completamente votato al blues e alle sue differenti forme. La prova più convincente è sul brano di Gillespie, “Kush”, un veloce valzer nel quale il clarinetto basso di De Franco emerge con quel suono scuro e misterioso sopra un pedale in Do minore. Qui, dove non ha bisogno di cambiare accordi e scale, riesce a tirare fuori il meglio dallo strumento e sia l’introduzione che l’assolo sono di ottima qualità. Ma anche su “Cousin Mary” De Franco è efficace, pur rivelando ogni tanto le sue innegabili difficoltà, e l’eccezionale drumming di Blakey ne intreccia le abili linee improvvisative, a riprova dell’elevato grado di interplay tra i due. Curioso è invece “Twelve Tone Blues”, il brano scritto da Feather e ispirato al sistema dodecafonico di Schoenberg, che ne fa una sorta di blues alla Third Stream. Sia Lee Morgan che De Franco utilizzano la scala esatonale per le loro improvvisazioni, ma i risultati sono alquanto differenti. Là dove il terreno si fa più avventuroso, meno conosciuto, i tratti caratteristici di De Franco emergono con tutta la loro forza determinando difficoltà espressive, accentuate dall’impossibilità di ricorrere pienamente al virtuosismo del suo clarinetto. Per quanto riguarda invece Lee Morgan, sia su questo brano che su “Rain Dance” lascia vedere tutta la ricchezza del suo vocabolario e la sua creatività in splendidi assoli, ben coadiuvato da un Feldman in ottima forma e da una ritmica dal moto incessante. Resta da dire di Curtis Fuller, che avvicina, soprattutto in “Rain Dance”, le sonorità e le atmosfere di questo disco ai Jazz Messengers, mentre Freddy Hill, l’altro trombettista, è presente solo su “Blues Connotation”, brano colemaniano inquadrato e trasformato in un semplice blues, lontano certo dalle idee del sassofonista.
In definitiva, siamo in presenza di un buon disco di jazz, nulla più nulla meno. Ma curioso per questo uso, diciamo così, abbastanza tradizionale di uno strumento come il clarinetto basso che tradizionale non era. E soprattutto, registrato e pubblicato a poca distanza dalla morte di colui che intorno a quello strumento aveva costruito la propria identità stilistica, mostrandolo al mondo in tutto il suo fascino e la sua complessità: Eric Dolphy. Chissà che ne avrebbe pensato. In ogni caso l’azzardo finì lì. De Franco fuggì sempre dalle insidie del clarone, forse scottato da questa storia, e tornò alle agili e svolazzanti note del suo clarinetto.
